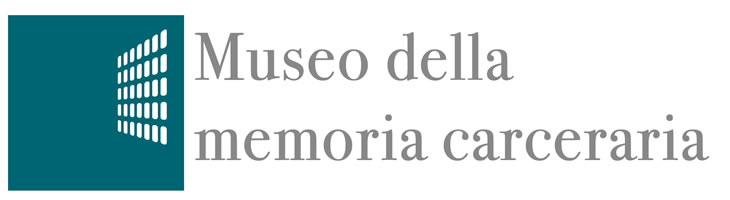Cucina, teatro: la seconda vita in carcere
Maschi oltre il 90% dei detenuti Il lavoro e l’impegno creativo riducono la recidiva a un terzo I benefici dell’attività sulla scena. Ma resta il nodo dell’affettività

C’è il riscatto dell’ex skinhead Luigi Celeste, omicida del padre-padrone, che è rinato con lo studio e, dopo aver scontato una condanna a nove anni, ora è un professionista esperto di sicurezza informatica: storia che ha raccontato in un libro emozionante, Non sarà sempre così (Mondadori). E c’è la conquista di Ahmed, una ragazzo egiziano finito dentro per spaccio di droga, partito da semianalfabeta e riuscito a diplomarsi grazie agli insegnanti volontari del Cpia: ora frequenta la Bocconi e dà ripetizioni al doposcuola. Ma c’è anche l’orgoglio di una compagnia teatrale di detenuti ed ex detenuti, Opera liquida, che nello spettacolo Undicesimo comandamento riflette sulla violenza contro le donne. Solo qualche esempio di uomini che cambiano dentro le mura del carcere, il luogo che più di tutti divide la società tra coloro che lo vedono esclusivamente come centro di punizione (e di perdizione, da cancellare dalla vista e dalla mente) e le centinaia di dirigenti, operatori, volontari che si impegnano ogni giorno per costruire un percorso di dignità e di recupero. Come indica, peraltro, l’art. 270 comma 3 della Costituzione, rinforzato dalla riforma carceraria del 1975 che mise fine all’impermeabilità degli istituti penitenziari rispetto al mondo esterno.
Oltre il 90% della popolazione carceraria è maschile. «Le percentuali di sempre, ma in 40 anni la natura degli ospiti è profondamente cambiata – spiega Luigi Pagano, provveditore dell’amministrazione penitenziaria lombarda -. Un tempo avevamo una delinquenza italiana in orizzontale, cioè con una radicalizzazione nel territorio molto elevata. Tanto per intenderci, le famiglie dei Vallanzasca, dei Turatello, dell’ndrangheta rurale. Oggi oltre il 50% dei carcerati è straniero. Ragazzi per lo più soli, senza une rete di parenti o amici e senza un’idea di futuro al di fuori delle strutture penitenziarie. Questa popolazione mette in crisi la stessa funzione del carcere, diventato un centro di assistenza di prima necessità».
Lo conferma Gloria Manzelli, direttrice della casa circondariale milanese di San Vittore, struttura in prima linea con i detenuti in attesa di giudizio che come molti altri penitenziari ha una squadra di comando femminile. «Da noi gli stranieri sfiorano il 70%. E per molti questo è il primo approdo sicuro: qui vengono vestiti, nutriti regolarmente, visitati dai medici, gli si offre di frequentare delle scuole. Soggetti che devono certo scontare una pena, ma comunque persone. E nonostante alcuni episodi di aggressività, spicca in loro la solitudine e la fragilità». «Molti sono drogati e rivelano un forte disagio mentale – spiega la funzionaria pedagogica Silvana Di Mauro –. Il supporto psicologico e psichiatrico è basilare, è previsto per tutti i detenuti; a chi arriva senza un documento cerchiamo di ricostruire un’identità. Un lavoro paziente da fare con i consolati». «Per parecchi bisogna considerare anche lo shock dopo un viaggio allucinante, le carceri libiche, la traversata e il salvataggio dai gommoni», aggiunge un’altra educatrice, Michelangela Barba, che mette in luce l’importanza degli agenti di rete «perché siamo chiamati a un lavoro anche fuori dal carcere come nella ricerca di case popolari che possano permettere di attuare, quando l’entità della pena lo consente, la custodia cautelare come misura alternativa».
Pur nell’emergenza costante della prima accoglienza e nella cronica mancanza di risorse, San Vittore è riuscita a mettere in piedi una serie di progetti che sono diventati un’eccellenza nel panorama penitenziario, come la sartoria che realizza gli abiti da sposa e le toghe dei magistrati o il laboratorio di pasticceria riservato ai giovani-adulti (18-25 anni). E poi i concerti di canto, gli incontri con gli scrittori e la proiezione in diretta su megaschermo della prima della Scala, diventata una tradizione nell’incontro con la cittadinanza. «Ogni iniziativa di cultura è un’occasione di curiosità, un’esperienza che molti non avrebbero potuto nemmeno considerare – riprende Di Mauro -. Due anni fa, assistendo al filmato dello show dell’Albero della Luce all’Expo, un detenuto venne a dirmi emozionato: io pensavo che questa musica la potessero ascoltare sono i ricchi… Aveva fatto la sua rivendicazione di class».
Con i suoi tre istituti penitenziari, Milano è lo specchio della difficile ma convinta scommessa per un carcere del recupero e del reinserimento. L’avanguardia è a Bollate, 1210 detenuti, di cui 1100 uomini con 35 ergastolani, 300 condannati per delitti a sfondo sessuale, 400 tossicodipendenti o alcoldipendenti. Qui con una popolazione che ha per l’80% un fine-pena medio, il rapporto italiani-stranieri si ribalta: i connazionali sono il 70%. Sin dalla sua costituzione, 17 anni fa, Bollate ha puntato al cambiamento e ironicamente viene soprannominato «il carcere a cinque stelle»: detenzione “dinamica”, piena libertà di movimento già molto tempo prima della sentenza Torreggiani (la condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti umani per trattamento degradante dovuto a sovraffollamento) che nel 2013 ha avuto come effetto l’apertura delle celle durante il giorno. A pranzo e a cena il ristorante stellato InGalera, all’interno della struttura, è un via vai continuo di gente. «Un mezzo mediatico efficacissimo: i detenuti coinvolti hanno imparato un mestiere, hanno capito cos’è la disciplina e il gioco di squadra; il pubblico ha la possibilità davanti a un piatto di pasta di riflettere sul carcere e di cambiare l’opinione sull’esecuzione pena», afferma il direttore Massimo Parisi.
Il nodo culturale è costituito dalle misure alternative alla carcerazione e Parisi è il primo ad ammettere che ogni caso di fuga è una fitta al cuore «perché danneggia un progetto utile alla società. Progetto che invece riduce sensibilmente la reiterazione del reato. I detenuti che lavorano all’esterno si spendono anche a favore degli altri, imbiancano le scuole, puliscono i parchi». Da un lato l’obbligo di garantire la giustizia, dall’altro la necessità di creare opportunità: a Bollate tutto si basa su un patto di fiducia che richiede nell’organizzazione un dialogo costante con le guardie carcerarie e con i detenuti. «Esaminiamo ogni problematica con i rappresentanti dei vari reparti e richiamiamo tutti al senso della collettività. Se qualcosa va storto, si decide per restrizioni momentanee: non a scopo punitivo ma per salvare il progetto. Ma allo stesso tempo se si lavora bene bisogna dirlo, la gratificazione è importante». A fronte di una media nazionale vicina al 70%, la recidiva a Bollate crolla al 20%. «Qualità delle relazioni certo, ma per essere credibile il carcere deve anche essere un posto di legalità, altrimenti rischia di fare da specchio alla propria utenza», afferma Roberto Bezzi, professore di scienza dell’educazione e diritto all’Università di Bicocca e responsabile dell’Area Educativa – Chiarito questo, il carcere deve riempirsi di contenuti».
Bezzi ha un collaboratore particolare, Gianluca Sanzano, che sconta una pena fino al 2024, «Sono giunto a Bollate – dice – dopo anni in istituti invivibili per sovraffollamento e abusi delle guardie. La riflessione sul danno che ho commesso l’ho fatta qui». Sanzano lavora allo sportello giuridico che esamina tutte le richieste dei detenuti, dai permessi alle telefonate, ai colloqui; inoltre organizza le attività sportive e porta in giro i numerosi visitatori che varcano i cancelli. «Soprattutto le scuole. Gli studenti arrivano ignari di tutto, seguono con sorpresa e interesse tutte le nostre attività, alcuni di loro vanno via piangendo per la commozione». A Bollate c’è una nutritissima libreria e c’è un maneggio che accoglie i cavalli maltrattati. «Usiamo attrezzi contundenti come i forconi per il fieno ma non abbiamo mai gli agenti alle calcagna». All’interno il lavoro coinvolge 250 detenuti, molti sono impiegati nella telefonia per Wind e 3 e in una cooperativa di call center, Bee 4, messa in piedi da un ex detenuto. La selezione tiene conto in primo luogo dei carcerati con pene lunghe. «Si arriva anche a prendere 1200 euro al mese, ai quali bisogna detrarre il mantenimento nella struttura. Resta del denaro che può aiutare la famiglia. Ma anche il compagno di cella che non ha avuto la possibilità di lavorare». Per chi lavora e ha in sentenza anche un risarcimento, viene aperto un libretto postale sul quale, a rate mensili, viene avviato il pagamento.
Mattia Archinito, 24 anni, una condanna all’ergastolo per un doppio omicidio, è tra coloro che testano i dispositivi di allarme prima di metterli sul mercato. «Curioso no?», dice con amara autoironia. Come si vive con un destino di fine pena mai? «Non mi sono reso conto subito di quello che ho fatto. Finché un giorno a un’udienza del processo non ho visto la mamma di uno dei due che ho ucciso piangere come la mia. E mi è venuta addosso tutta la realtà. E’ stata dura non esserne schiacciati per il rimorso. Mi sono detto: d’ora in avanti dovrò fare qualcosa di costruttivo, dovrò sempre impegnare la mente». Mattia si è diplomato in ragioneria, oltre al lavoro ci sono il maneggio e il pugilato che ha praticato sin da ragazzino. E poi i laboratori di falegnameria. I suoi orizzonti: dopo otto anni di percorsi lavorativi potrà arrivare qualche permesso, dopo 16 si potrà sperare in una semilibertà condizionale. E l’amore, il sesso? «Ho detto alla mia ragazza di rifarsi una vita, ma lei continua a venire a trovarmi. Più che il sesso è l’affettività che ci viene negata. E questo lo trovo profondamente ingiusto».
Un dibattito, quello dell’affettività dei detenuti, sempre più in primo piano. A svelare senza remore i propri sentimenti sono coloro che si avvicinano al teatro. «Il lavoro sul corpo ci dà fiducia e forza – dice Christian Fiore, fine pena 2035, ora socio della cooperativa Estia, tuttofare dal tecnico luci al manovratore di scena, oltre che attore -. Il pubblico viene a vederci recitare nel nostro teatro dentro il carcere, paga un biglietto, ci applaude per quello che mostriamo in scena, senza pregiudizi. Alla fine c’è l’incontro, il dialogo. Per noi è molto gratificante».
Il teatro è il formidabile motore di trasformazione in molti istituti penitenziari della penisola. Capostipite, nel 1988, il Teatro Fortezza di Volterra, guidato dal drammaturgo Armando Punzo. Oggi si va dall’esperienza ventennale a Palermo dell’attore Lollo Franco che opera all’Ucciardone («Qui una volta i mafiosi gestivano il mondo, mentre oggi mettiamo in scena la Via crucis») agli exploit degli attori di Rebibbia consacrati nel film dei fratelli Taviani Cesare deve morire. Ma è il terzo carcere milanese, quello di Opera, ad analizzare i benefici che scaturiscono dall’attività scenica. «Questo è stato il primo carcere ad avviare un laboratorio del musical per i detenuti di massima sicurezza», spiega il direttore Giacinto Siciliano che ha dato una decisa sterzata culturale alle attività del carcere. «In generale, grazie ai benefici delle attività pedagogiche, abbiamo potuto ridurre in pochi anni gli agenti di sorveglianza da 80 a 42». Per i carcerati di media sicurezza, c’è tra le varie progettualità teatrali, la realtà di Opera Liquida che organizza un festival dentro e fuori la struttura penitenziaria. «Abbiamo cominciato nel 2009 con uno spettacolo sul senso della vita ispirato dal coma vegetativo di Luana Englaro, – racconta la regista e fondatrice della compagnia Ivana Trettel – ora con Disequilibri circensiriflettiamo sulla diversità e le distanze culturali: un laboratorio di 12 attori multietnici. La cosa che mi sorprende è la presenza costante nelle mie compagnie di ex detenuti diventati attori professionisti che tornano all’interno del carcere per creare con noi gli spettacoli. Una prova di attaccamento che è anche un esempio di riscatto».
Analizzando le attività culturali di Opera (anche con un dettagliato questionario posto a un campione di 270 detenuti) Filippo Giordano, docente di Social Entrepreneurship and Impact Investing presso l’Università Bocconi e Ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università LUMSA di Roma, ha coordinato la ricerca L’impatto del teatro in carcere – Misurazione e cambiamento del sistema. «La trasformazione è evidente in rapporto a chi non fa nessuna attività. Dati alla mano, il teatro porta anche un benessere fisico: diminuiscono le richieste di visite mediche, si riducono gli episodi di autolesionismo, si stempera la conflittualità. Sorprendente, inoltre, come cambi l’atteggiamento della polizia penitenziaria verso il detenuto-attore, come si crei una relazione, anche se sulla carta il dover accompagnare la compagnia all’esterno del carcere per gli spettacoli genera stress e maggior lavoro».
Insomma, i segni del cambiamento ci sono, ben evidenti, nel mare delle emergenze e dei drammi che costellano il sistema carcerario italiano. Ed è l’apporto della società civile, dal sostegno economico per i progetti all’impegno delle migliaia di volontari, a garantire molte attività. Sì perché se si dovesse contare solo sui soldi pubblici questa realtà educativa e di recupero sarebbe ridotta al lumicino. «Ogni detenuto – riprende Giordano – costa allo Stato in media oltre 140 euro al giorno ma solo l’8% di questa cifra è destinata al soggetto, il resto serve a mantenere e a far funzionare tutto il sistema. Ebbene, di quell’8%, appena un 2,5% viene impiegato per attività trattamentali». Tradotto in spiccioli, poco più di 20 centesimi.